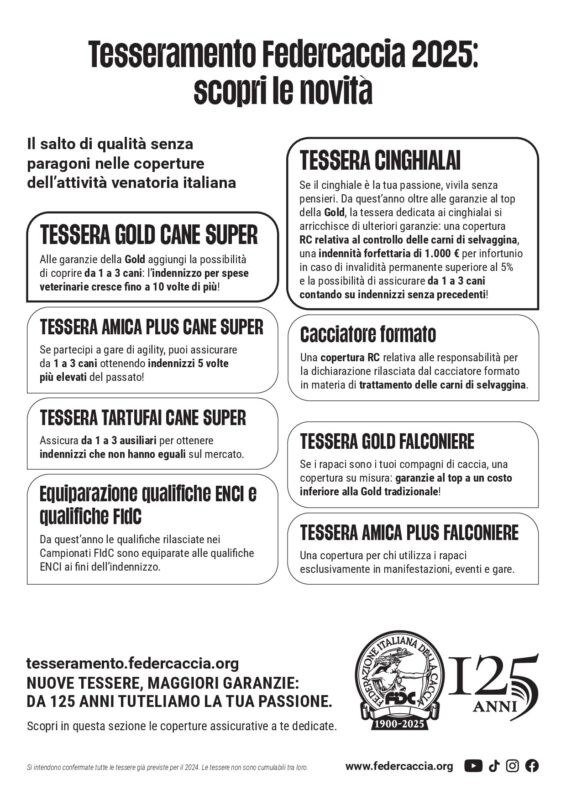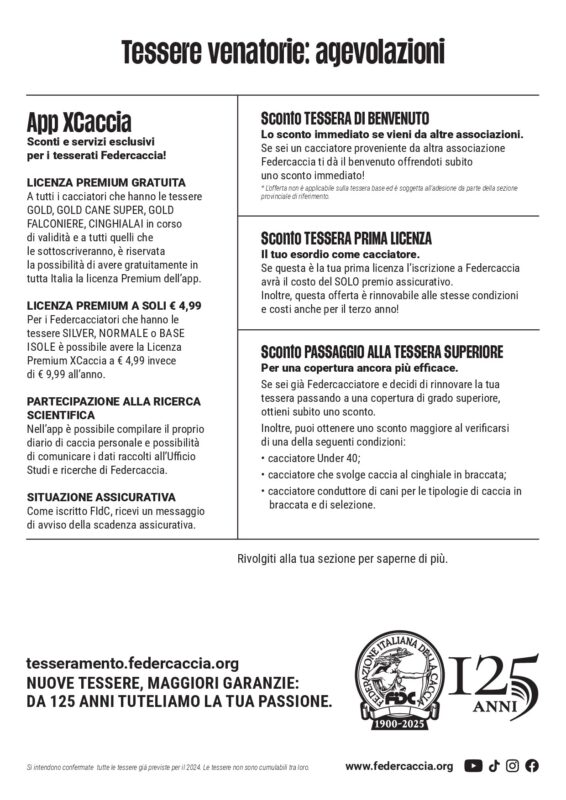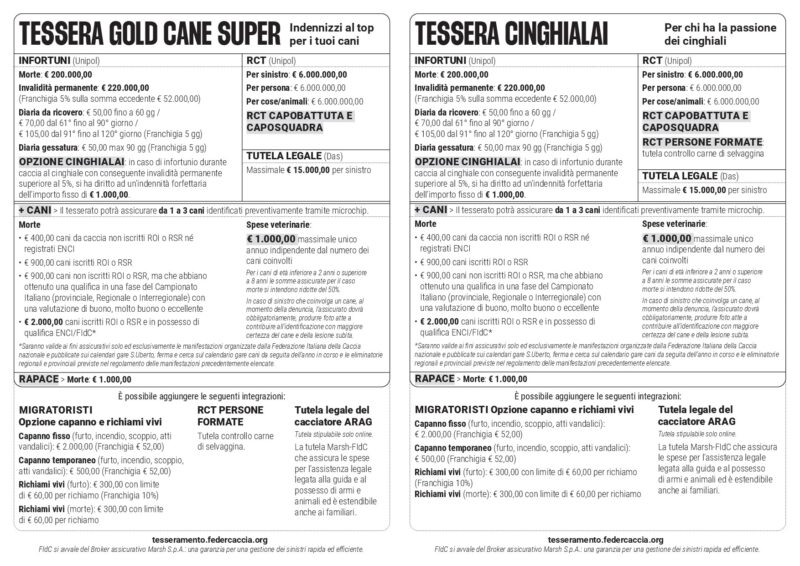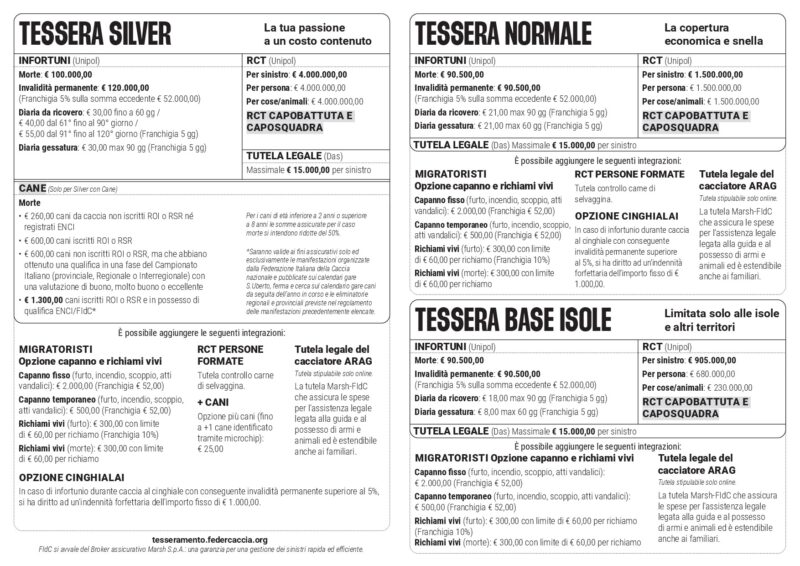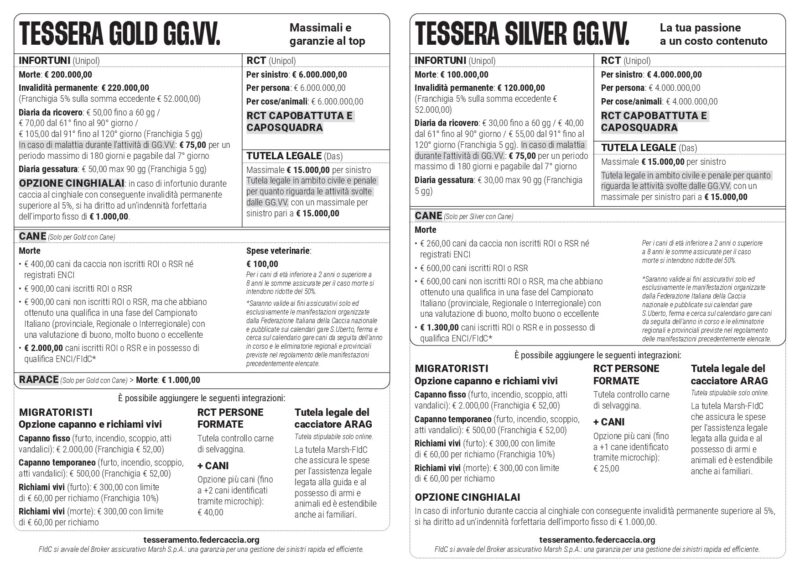LE CONTRODEDUZIONI DELL’UFFICIO STUDI DI FEDERCACCIA AL DOSSIER CACCIA DELLA FONDAZIONE CAPELLINO.


CONTRO DOSSIER DOCUMENTO FONDAZIONE CAPELLINO-ALMO NATURE SULLA CACCIA IN ITALIA E IN EUROPA
Valutazioni generali
La Fondazione Capellino, che ha recentemente promosso a livello nazionale una campagna contro l’attività venatoria e la proposta di modifica della Legge 157/92 attualmente in esame in Parlamento, è la proprietaria al 100% dell’azienda Almo Nature, come descritto nel proprio sito internet https://fondazionecapellino.org/it/fondazione-capellino.
Almo Nature vende prodotti alimentari per cani e gatti, oltre a lettiere per gli stessi. Come riportato nel proprio sito internet, i prodotti alimentari per cani e gatti della società Almo Nature contengono carni di vari animali, incluso il cinghiale, oltre a pesce di varie specie, come si può vedere ai seguenti link:
•
https://www.almonature.com/it/prodotti-per-cani;
•
https://www.almonature.com/it/prodotti-per-cani/5572/HFC-HFC-Natural-Cinghiale-con-Prosciutto-e-Frutti-di-Bosco?utm_source=products&utm_content=5572;
•
https://www.almonature.com/it/prodotti-per-gatti.
Già da questa premessa la posizione di Fondazione Capellino sulla caccia, nonché la pagina iniziale del sito https://www.almonature.com/, dove compare un video intitolato “Niente giustifica la caccia”, appaiono del tutto incoerenti, considerando che per i propri prodotti la società Almo Nature utilizza carne di cinghiale (oggetto di caccia), oltre a quella di animali da reddito, che evidentemente per il Consiglio di amministrazione di Fondazione Capellino possono essere allevati, abbattuti e consumati senza nessun problema etico.
Quindi, nello stesso tempo, Fondazione Capellino dichiara la caccia un’attività contro il benessere animale e una minaccia per la biodiversità, ma utilizza la carne di cinghiale e di pesci di varie specie per il proprio lucro.
Pecunia non olet, direbbero i latini, ma la contraddizione e l’incoerenza in questo caso sono lampanti.
FIdC – Federazione Italiana della Caccia | Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali
Via Garigliano, 57 – 00198 Roma | C.F. 97015310580 | fidc@pec.it | studiericerche@fidc.it | tel. 06/844094207-204
FedercacciaNazionale | www.federcaccia.org
A livello generale le argomentazioni sulla caccia sono infondate, approssimative e descritte con tono sensazionalistico, un approccio tipico delle associazioni ideologicamente contro l’attività venatoria. Di seguito un’analisi approfondita dei punti trattati dal dossier di Fondazione Capellino che ha accompagnato la campagna video.
Benessere animale
Il dossier esordisce affermando: “La caccia ha diversi impatti negativi sul benessere animale”, tuttavia, alla luce dell’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), se da un lato si garantisce il rispetto del benessere animale, dall’altra s’impone anche il rispetto delle consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.
L’attività venatoria è praticamente coeva alla storia umana e sebbene abbia perso ormai il suo carattere originario di prevalente – se non addirittura esclusiva – fonte di sostentamento delle comunità, rappresenta parimenti una parte della tradizione sociale e culturale italiana, senza contare che la caccia persegue oggi una finalità non solo ricreativa ma anche di misura di conservazione del patrimonio animale (si pensi all’abbattimento selettivo di specie reputate eccessivamente invasive oppure all’abbattimento per limitare la diffusione di gravi patologie quali la peste suina africana) ad es. TAR Lombardia (S. II) sent. n. 02583 del 7.10.2024.
L’ordinamento dell’Unione Europea (UE) non vieta certamente la caccia: si veda ad esempio la Direttiva UE 2009/147/CE (Direttiva “Uccelli”), che ammette (decimo “considerando”) talune specie possano essere oggetto di caccia, costituendo questa un modo ammissibile di uso di una risorsa naturale rinnovabile (modalità di fruizione di servizi ecosistemici e di valorizzazione del Capitale Naturale costituito dalla fauna selvatica), seppure nel rispetto di ben precisi e determinati limiti.
Anche il Consiglio d’Europa, nella Carta della caccia e della biodiversità (Principio 6) contempla la nozione di “caccia sostenibile”, ovvero nel rispetto della biodiversità e delle inderogabili esigenze di tutela ambientale e animale.
La recente introduzione della tutela degli animali negli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana (Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1) rappresenta una formale aderenza all’art. 13 TFUE, un fatto apprezzabile in quanto ha colmato un vuoto di disciplina nell’ordinamento. Ancorché la norma sia ora inserita nei Principi Fondamentali, essa “appare di carattere programmatico e non immediatamente precettivo, creando una riserva di legge statale sulle modalità di tutela degli animali e rinviando quindi l’individuazione concreta di tali forma di tutela alle scelte del legislatore statale” ad es. TAR Lombardia (S. II) sent. n. 02583 del 7.10.2024. Di fatto tali scelte,
FIdC – Federazione Italiana della Caccia | Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali
Via Garigliano, 57 – 00198 Roma | C.F. 97015310580 | fidc@pec.it | studiericerche@fidc.it | tel. 06/844094207-204
FedercacciaNazionale | www.federcaccia.org
in armonia con le Direttive Natura europee, sono sancite dalla lex specialis 11 febbraio 1992, n.157 e dalle leggi regionali di recepimento.
Anche la recentissima Legge n. 82 del 6 giugno 2025 sul benessere animale è principalmente rivolta al benessere degli animali domestici, d’affezione, d’allevamento, durante il trasporto e nella macellazione; la disciplina specifica sulla fauna selvatica continua ad essere prevalentemente regolata da norme speciali (in particolare la Legge n. 157/1992).
La tutela della fauna selvatica è dunque disciplinata da norme speciali e autonome rispetto alla normativa sul benessere animale (primato della lex specialis), per cui la legge sul benessere animale conferma i principi fondamentali, ma non abroga o sostituisce parti della Legge 157/1992, né le competenze regionali né, ovviamente, interferisce con le Direttive europee in materia di conservazione dell’ambiente, le quali contemplano espressamente e regolano la caccia.
Il dossier afferma inoltre: “La pratica è spesso non selettiva: possono essere feriti o uccisi individui non bersaglio, come giovani, femmine gravide o specie protette, compromettendo la sopravvivenza della popolazione”.
In primo luogo, occorre considerare che l’uso del fucile “rappresenta un metodo di uccisione selettivo” [Corte di giustizia europea, Sentenza del 9 dicembre 2004, Commissione/Spagna, causa C-79/03, Racc. 2004. Ciò non esclude l’eventualità di abbattimenti involontari o volontari (bracconaggio), comunque sempre sanzionabili a norma di legge. In secondo luogo, la normativa italiana e la Direttiva 2009/147/CE (Uccelli) prevedono non solo la tutela delle specie durante il periodo riproduttivo o di dipendenza dei giovani, ma anche la salvaguardia dei singoli individui durante la fase di migrazione prenuziale, sin dagli esordi, stabilendo al tal fine periodi di divieto ben precisi (Key Concepts).
Altro assunto del dossier è che “la caccia interferisce con i comportamenti naturali degli animali, costringendoli a modificare alimentazione, riproduzione e migrazione”.
Sulla riproduzione e la migrazione si è pocanzi già eccepito, sull’alimentazione si trascura l’esistenza di norme specifiche che vietano la caccia in determinati orari e giornate (l’Italia è l’unico Stato europeo ad aver definito delle giornate di “silenzio venatorio”) e in talune condizioni, ad esempio di innevamento, di terreno gelato (ISPRA ha definito un protocollo di tutela della beccaccia in caso di ondate di gelo, puntualmente recepito dalle Regioni), con specchi d’acqua gelati.
Inoltre, la gestione della fauna selvatica promossa attraverso la caccia implica una molteplicità di misure di miglioramento ambientale, che prevedono anche misure di coltivazioni a perdere per la selvaggina, ma di cui si avvantaggia tutta la fauna. Persino, in determinate condizioni (come in caso
FIdC – Federazione Italiana della Caccia | Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali
Via Garigliano, 57 – 00198 Roma | C.F. 97015310580 | fidc@pec.it | studiericerche@fidc.it | tel. 06/844094207-204
FedercacciaNazionale | www.federcaccia.org
di innevamento) sono da più parti attivate misure di foraggiamento artificiale. Questo è particolarmente importante nel caso delle specie che a livello nazionale presentano uno stato di conservazione non ottimale, per le quali sono redatti dall’ISPRA dei Piani d’Azione e dei Piani di gestione attuati dalle Regioni e dalle Organizzazioni venatorie (ATC, AFV, Associazioni, etc.).
Si trascura, peraltro, che la fauna selvatica è costantemente soggetta ad una ferrea selezione naturale che ha plasmato le specie secondo comportamenti ben diversi da quelli degli animali domestici o immaginabili dalle persone comuni. I rari casi di malnutrizione riscontrabili sulla selvaggina prelevata durante l’attività venatoria sono di norma riconducibili a gravi parassitosi o a patologie.
Critica alla gestione “post-caccia” della fauna selvatica
Il recupero dei capi abbattuti o feriti fa parte dell’essenza stessa della caccia e costituisce un obiettivo primario del cacciatore e i cani sono una parte essenziale di questo processo. Oltre a rappresentare una forma di rispetto per la fauna selvatica cacciata secondo l’etica venatoria, si configura anche come un intervento volto a minimizzare le sofferenze agli animali cacciati.
Secondo gli estensori del dossier, in alcuni casi avverrebbe la macellazione sul campo degli animali non garantendo “criteri di umanità, ampliando la sofferenza”. In primo luogo, si tratta, semmai, di capi di selvaggina già deceduta, per cui la sofferenza è del tutto fuori luogo, inoltre, il tema non riguarda la piccola selvaggina e nel caso della grossa selvaggina le regole vietano tale partica per ragioni sanitarie. Soprattutto nel caso del cinghiale, le norme obbligano le squadre alla disponibilità di punti di raccolta e di macellazione delle carcasse con smaltimento prescritto degli scarti.
Anche in questo caso la posizione della Fondazione Capellino risulta incoerente e per questo inaccettabile, considerando la vendita da parte della società Almo Nature di molteplici prodotti alimentari per animali composti anche da carni di pesci di molte specie.
La pressione venatoria sulla fauna italiana: abbattimenti e uccisioni
Il documento di Fondazione Capellino riporta argomentazioni generiche senza dettaglio delle specie e che non sono confrontate con le consistenze delle popolazioni, per questo motivo quanto riportato non ha alcun valore tecnico-scientifico.
Fondazione Capellino ignora totalmente che la Commissione Europea ha recentemente analizzato le specie cacciabili in Unione europea e l’impatto del prelievo su 33 specie di uccelli migratori ritenuti in sfavorevole stato di conservazione. Una gran parte delle specie cacciabili in Italia non è nemmeno compresa nell’elenco, essendo in uno stato di conservazione favorevole, e delle 33 specie analizzate solo 3 sono state prescelte per un piano di prelievo adattativo che affronterà, tra l’altro, anche la gestione venatoria al fine di gestirne la sostenibilità.
FIdC – Federazione Italiana della Caccia | Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali
Via Garigliano, 57 – 00198 Roma | C.F. 97015310580 | fidc@pec.it | studiericerche@fidc.it | tel. 06/844094207-204
FedercacciaNazionale | www.federcaccia.org
Un quadro ben diverso dalle affermazioni avventurose della Fondazione Capellino, che ha definito la caccia un fattore che determina il declino delle popolazioni cacciate. Gli autori del dossier evidentemente ignorano quante specie cacciabili, tra cui molti anatidi e negli ultimi anni anche la tortora, sono in aumento o stabili in tutta Europa (alzavola, fischione, codone, mestolone, moretta, tordo bottaccio, cesena, beccaccia, frullino, beccaccino, gallinella d’acqua, colombaccio, ecc.).
Inoltre, la compatibilità del prelievo non si valuta col numero “assoluto” di capi abbattuti, ma in rapporto all’entità delle popolazioni, al suo stato di conservazione e alla sua tendenza demografica su lunghi periodi. Il dossier della Fondazione Capellino non riporta nemmeno per una specie la stima della popolazione complessiva. Ad esempio, per il tordo bottaccio la caccia viene esercitata su una popolazione globale stimata in non meno di 194 milioni di soggetti, per cui si comprende che il prelievo di alcuni milioni si attesta su percentuali minime dell’incremento utile annuo.
I commenti sul Rapporto ISPRA sui prelievi dal 2017/18 al 2022/23 sono infondati, si ignora volutamente il forte miglioramento nel monitoraggio dei carnieri avvenuto nelle ultime stagioni riportate nel documento e la collaborazione delle Regioni a tale risultato.
Altrettanto scorretto è unire il bracconaggio con la caccia, per sua natura legale, in un documento che si riferisce appunto all’attività venatoria come regolata dalle leggi italiane.
Impatto sulla biodiversità
Il documento di Fondazione Capellino afferma genericamente che il declino delle specie cacciate rappresenta una “preoccupazione crescente per la conservazione della biodiversità”, citando in modo generico “tortora e anatidi” quali specie che avrebbero subito un decremento dovuto alla caccia insieme ad altri fattori.
Come sopra descritto, tutti gli anatidi cacciabili sono in aumento in Italia come svernanti, quindi nel periodo di caccia, secondo il più recente dato disponibile (Zenatello et al. 2020). Anche a livello internazionale i dati più recenti dei censimenti invernali – cioè il più importante monitoraggio in atto su queste specie – fornisce un quadro complessivamente favorevole (https://iwc-wi.shinyapps.io/csr9/). La tortora dimostra in Italia un periodo di stabilità dal 2021 e un aumento nel 2024 (https://www.reterurale.it/farmlandbirdindex). Questa specie ha mantenuto per molti anni una popolazione stabile o anche in aumento quando la caccia era molto più intensa. Ciò significa senza alcun dubbio che il problema di base non è la caccia bensì le condizioni degli habitat.
Il mondo venatorio italiano da sempre contribuisce alla conservazione e al ripristino della biodiversità, realizzando miglioramenti ambientali, monitorando e gestendo la fauna, collaborando
FIdC – Federazione Italiana della Caccia | Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali
Via Garigliano, 57 – 00198 Roma | C.F. 97015310580 | fidc@pec.it | studiericerche@fidc.it | tel. 06/844094207-204
FedercacciaNazionale | www.federcaccia.org
alla pulizia degli ambienti naturali, tutto a proprie spese o con il volontariato dei cacciatori. Solo alcuni esempi in merito sono il ripristino e la conservazione di migliaia di ettari di zone umide, la gestione ambientale dei siti ove si collocano gli appostamenti fissi di terra e d’acqua, le azioni di conservazione di siepi, boschetti, colture a perdere realizzate dagli ATC e CA, gli interventi di apertura di radure a vantaggio dei galliformi alpini, il monitoraggio di questi e degli ungulati, i censimenti della piccola fauna stanziale, i numerosi studi scientifici prodotti e in corso da parte dell’Ufficio Studi e Ricerche di Federcaccia (https://www.biodiversitymanifesto.com/).
Si parla di “caccia non selettiva”, di “caccia non regolamentata” e di “caccia non sostenibile” come elementi che contribuiscono alla perdita di biodiversità insieme ad altri fattori antropici. Questo è vero in quanto la caccia “non regolamentata” non è ammissibile o è da considerarsi bracconaggio, mentre la caccia “non selettiva” e la “caccia non sostenibile” non hanno ragione di esistere, per cui non si riesce a capire a che tipo di caccia si voglia fare riferimento con queste terminologie.
L’attività venatoria in Italia è regolamentata in tutti i suoi aspetti e i periodi di caccia, con i relativi quantitativi da prelevare, sono basati su dati scientifici affinché si pratichi solo ed esclusivamente una caccia conservativa e soprattutto sostenibile con l’ambiente.
L’interesse del mondo venatorio è chiaramente quello del mantenimento nel tempo della caccia e delle specie cacciabili.
Inquinamento ambientale
Il dossier pubblicato da Fondazione Capellino cita come fonte autorevole il report condotto da ISPRA, nel 2012, utilizzando una sola frase, peraltro decontestualizzata. Non vi è alcun riferimento al fatto che nel report è espressamente dichiarato che i calcoli sono stati fatti “ipotizzando un peso medio delle cartucce piuttosto elevato” e che “è possibile che rappresenti una sovrastima”. Analogamente non vi sono riferimenti al fatto che dal 2006 a oggi il numero dei cacciatori è calato drasticamente, da 756.000 nel 2006 a circa 500.000 nel 2024, né tanto meno al vigente divieto di utilizzo del piombo in diversi contesti ambientali, siano essi ricadenti in ZSC o in ZPS (DM 17 ottobre 2007).
È inoltre totalmente trascurato il sempre crescente passaggio alle munizioni monolitiche (atossiche) per la caccia di selezione agli ungulati che, qualora feriti e non recuperati, potrebbero essere consumati da predatori o specie necrofaghe.
Sul piano strettamente ambientale, sintetizziamo il contenuto di un approfondimento dedicato alla biodisponibilità dei metalli pesanti nei suoli agricoli evidenziando la capacità di alcuni metalli di interagire con le piante e le acque, attraverso il suolo, presente nel portale web della Regione Emilia-Romagna. Si legge che il piombo (Pb) ha una biodisponibilità effettiva bassa, sia
FIdC – Federazione Italiana della Caccia | Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali
Via Garigliano, 57 – 00198 Roma | C.F. 97015310580 | fidc@pec.it | studiericerche@fidc.it | tel. 06/844094207-204
FedercacciaNazionale | www.federcaccia.org
verso le piante che verso le acque; nel paragrafo “Breve analisi dei risultati”, si può leggere “Cr, Sn, As e Pb presentano valori sistematicamente più bassi di almeno un ordine di grandezza. Non esiste una correlazione tra il contenuto totale e quello biodisponibile”.
Un ulteriore studio, il progetto RAMET, realizzato nel 2007 in Lombardia da ERSAF in collaborazione con l’Università di Pavia, è invece focalizzato su tre aree agricole della pianura lombarda (Oltrepò Pavese, Lomellina, Pianura cremonese); identifica come principali fonti di contaminazione da piombo le emissioni industriali, i veicoli a motore e l’uso di fanghi agricoli, spesso ricchi in metalli pesanti. L’attività venatoria, al contrario, non viene indicata come fonte rilevante.
Pericolosità per gli esseri umani
L’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, nell’ambito di uno studio dedicato agli incidenti che si verificano durante la pratica delle attività outdoor, ha pubblicato il 31 gennaio 2025 un comunicato in cui ne riassume i principali risultati.
Nel corso del 2024 (anno solare), in Italia si sono registrati 14 decessi direttamente riconducibili all’attività venatoria e 34 feriti, in diminuzione rispetto ai 53 del 2023. Tra le vittime figura una persona estranea alla caccia, mentre tra i non cacciatori si contano 9 feriti.
Lo studio specifica che i dati sono filtrati da eventi non imputabili alla pratica venatoria, come malori, cadute accidentali, atti intenzionali o episodi di bracconaggio. Questo approccio metodologico, basato sulla selezione delle sole cause direttamente connesse all’uso legale delle armi da caccia, consente una rappresentazione più precisa e meno allarmistica del fenomeno.
La ricerca dell’Università di Urbino ha inoltre analizzato il tasso di incidentalità di altre attività outdoor, collocando la caccia tra quelle a minor rischio relativo. Nel 2024, infatti, si sono registrati 119 morti e 305 feriti nell’escursionismo (principalmente dovuti a cadute in dirupi o burroni), 87 morti e 13 feriti nella balneazione (escludendo i malori), 13 morti e 60 feriti negli sport invernali, 30 vittime nelle attività subacquee e 5 nell’alpinismo o arrampicata.
Pertanto, pur riconoscendo la necessità di una continua prevenzione e formazione dei cacciatori in materia di sicurezza e di campagne di sensibilizzazione, nonché di monitoraggio costante, il risultato dell’analisi condotta dall’Università degli Studi di Urbino, evidenzia come le cifre citate dalla Fondazione Capellino, prese da comunicazioni di alcune associazioni ideologicamente anticaccia, sono spesso basate su conteggi grezzi e comprensivi di eventi non pertinenti e per questo non riflettono accuratamente la dimensione reale e statisticamente validata del rischio in campo venatorio.
FIdC – Federazione Italiana della Caccia | Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali
Via Garigliano, 57 – 00198 Roma | C.F. 97015310580 | fidc@pec.it | studiericerche@fidc.it | tel. 06/844094207-204
FedercacciaNazionale | www.federcaccia.org
Richiami vivi
Si premette che nessuna normativa comunitaria vieta l’utilizzo di richiami vivi nell’esercizio della caccia. Alcune procedure della Commissione Europea ed alcune sentenze della Corte di Giustizia Europea hanno stabilito che non sia in linea con la Direttiva la cattura massiccia e continua di soggetti di avifauna cacciabile a scopo di richiami vivi. Per questo motivo oggi in Italia è sospesa la pratica della cattura di avifauna cacciabile da utilizzare come richiami vivi, mentre è consentito l’utilizzo di soggetti di allevamento. L’impiego di richiami vivi provenienti da allevamenti autorizzati e controllati rappresenta quindi una pratica regolamentata in Italia e conforme al diritto comunitario (Direttiva 2009/147/CE),
I richiami vivi di allevamento vengono oggi impiegati in Italia nel rispetto delle normative nazionali ed europee, attraverso condizioni che ne garantiscono la piena legittimità e sostenibilità:
1.
Origine certificata e tracciabile: ogni esemplare proviene da allevamenti autorizzati e registrati, con apposizione di un anello inamovibile e documentazione ufficiale a supporto che ne certifica la provenienza.
2.
Benessere animale: le condizioni di detenzione (dimensioni delle voliere, delle gabbie, alimentazione, esposizione, ecc.) sono ben regolate dalle normative e sottoposte al controllo delle autorità competenti.
3.
Controlli sanitari: i richiami vivi d’allevamento, prima di essere ceduti, sono sottoposti a verifiche veterinarie, a garanzia della salute dell’animale, nel rispetto delle normative regionali e nazionali.
4.
Utilizzo regolamentato: la disciplina dell’uso di richiami vivi è definita all’interno della legge 157/92 oltre che da regolamenti regionali, con limiti temporali d’impiego e quantitativi stringenti.
5.
Controlli e sanzioni: esistono meccanismi di vigilanza e controllo contro il traffico illecito di richiami vivi selvatici, la contraffazione di anelli o la falsificazione di documenti, demandati dalla legge alle autorità competenti che notoriamente applicano anche ricorrendo a mezzi d’indagine sofisticati, soprattutto in alcuni contesti locali.
6.
Possibilità di derogare all’utilizzo esclusivo di tali richiami attraverso l’attività di cattura temporanea per cessione ai fini di richiamo esclusivamente mediante mezzi, impianti o metodi di cattura non vietati ai sensi dell’Allegato IV della Direttiva 2009/147/CE. Tale possibilità teorica è ammessa al fine di migliorare gli stock degli allevamenti già autorizzati di richiami vivi, oppure di rimediare ad eventuali perdite, garantendo così un
FIdC – Federazione Italiana della Caccia | Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali
Via Garigliano, 57 – 00198 Roma | C.F. 97015310580 | fidc@pec.it | studiericerche@fidc.it | tel. 06/844094207-204
FedercacciaNazionale | www.federcaccia.org
approvvigionamento rigidamente controllato e sostenibile di esemplari per l’attività venatoria.
L’utilizzo dei richiami vivi rappresenta inoltre una pratica venatoria tradizionale e profondamente radicata nella cultura rurale italiana, in particolare per quanto riguarda la caccia da appostamento agli uccelli migratori. Questo valore storico e identitario, riconosciuto anche da numerose Regioni e comunità locali (ad esempio la Fiera Primaverile degli Uccelli di Sacile, in provincia di Pordenone o la Fiera Nazionale degli Uccelli di Capannoli, in provincia di Pia), merita considerazione non soltanto nel quadro delle politiche faunistiche e venatorie nazionali. Ovviamente, la salvaguardia delle tradizioni non può prescindere dal rispetto dei vincoli posti dagli orientamenti giuridici, dalla scienza e dal principio di sostenibilità ambientale. In quest’ottica, l’utilizzo di richiami vivi da allevamento rappresenta oggi un punto di equilibrio tra conservazione e tradizione, permettendo di mantenere vitale una pratica venatoria storica, compatibile con il benessere degli animali allevati in cattività.
Saturnismo e inquinamento da piombo
Sono ormai numerose le pubblicazioni scientifiche che hanno indagato gli effetti dei pallini delle munizioni da caccia sulle specie che possono eventualmente ingerirli, principalmente rapaci, uccelli acquatici e granivori. Molte popolazioni di rapaci in Europa sono aumentate negli ultimi decenni a seguito di una maggiore protezione e della riduzione nell’uso dei pesticidi e del bracconaggio.
Anche in Italia, secondo il Report dell’Articolo 12, 2013-2018 redatto dall’ISPRA, diverse popolazioni di rapaci, ad esempio lo sparviere e il gheppio, sono in aumento, e sono specie che possono facilmente cibarsi di uccelli feriti dai cacciatori con cartucce contenenti piombo. Lo stesso può dirsi per i predatori opportunisti, in particolare per alcune specie di corvidi e la volpe che potrebbero essere degli ottimi indicatori, ma ad oggi non vi sono dati disponibili di contaminazione da piombo su queste specie, né segnalazioni di mortalità per saturnismo. Al contrario, sono tutte specie in stato di conservazione favorevole, tanto abbondanti da essere oggetto di contenimento.
In generale, le tendenze delle popolazioni di rapaci sono favorevoli e non direttamente correlate ai casi di mortalità per intossicazione da piombo, poiché evidentemente sono altri i parametri che determinano la demografia delle popolazioni. Nel caso dei Vulturidi, specie più rare e longeve, che si sono notevolmente avvantaggiate dei progetti di reintroduzione e delle strategie di gestione venatoria degli ungulati (in forte incremento sia in Italia che in Europa) si sono verificati dei casi di mortalità per saturnismo, tuttavia si tratta di un problema superabile attraverso i
FIdC – Federazione Italiana della Caccia | Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali
Via Garigliano, 57 – 00198 Roma | C.F. 97015310580 | fidc@pec.it | studiericerche@fidc.it | tel. 06/844094207-204
FedercacciaNazionale | www.federcaccia.org
divieti di rilascio di visceri di ungulati sul campo e con la diffusione dell’uso di munizioni non contenenti piombo, già in atto in varie zone dell’arco alpino e non solo.
Per quanto riguarda gli uccelli acquatici, benché vi siano differenze ovviamente tra le specie, nel complesso le tendenze degli svernanti in Italia sono positive, come dimostrano i risultati dei censimenti invernali (coordinati dall’ISPRA) per il periodo 2009-2018, essendo passati da 1.609.132 a 2.030.129 individui, ivi compresi gli anatidi, che registrano un 22% d’incremento (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 151 del 30-6-2023).
In riferimento al rischio di intossicazione da consumo di carne contaminata, è opportuno ricordare che pur riconoscendo la tossicità del piombo, soprattutto per i bambini e le donne in gravidanza che vanno tutelati con misure specifiche, deve essere considerata l’effettiva incidenza del consumo di selvaggina cacciata con munizioni in piombo sull’organismo umano. In tal senso, uno studio condotto nel 2017 dall’Università degli Studi di Milano ha misurato i livelli di piombo nel sangue di consumatori abituali di selvaggina. I risultati non hanno evidenziato differenze significative rispetto ai non consumatori, escludendo così una correlazione diretta tra consumo di carne cacciata e livelli di piombo nel sangue.
Infine, proprio nello studio di EFSA “Lead dietary exposure in the European population”, a cui i fa riferimento nel dossier della Fondazione Capellino, si legge che secondo l’Autorità, tra le categorie alimentari che contribuiscono in modo significativo all’esposizione alimentare al piombo, figurano il pane (8,5 %), il tè (6,2 %), l’acqua del rubinetto (6,1 %), le patate e i prodotti a base di patate (4,9 %), i prodotti lattiero-caseari fermentati (4,2 %) e la birra e le bevande simili (4,1 %), anche se questi dati variano a seconda delle fasce d’età e delle indagini.
Rispetto delle normative internazionali sulla caccia, la “Lobby venatoria” e deroghe regionali
La critica di mancato rispetto delle normative internazionali inerenti alla regolamentazione della caccia è una generalizzazione strumentale descritta in modo distorto.
L’incompleto o inadeguato rispetto delle normative comunitarie, che si traduce rare volte in procedure d’infrazione, è un tema che abbraccia tanti settori e non esclusivamente quello venatorio, inoltre, integra anche oggettive e legittime difformità d’interpretazione della normativa stessa. Infatti, sono circa sessanta le procedure d’infrazione che la Commissione europea mantiene aperte contro l’Italia, ma solo due riguardano il settore faunistico-venatorio, tra l’altro verso le quali il Governo attuale si è adoperato per confutarne le tesi (Decreto-legge del 16/09/2024 n. 131).
Il concetto è quindi utilizzato dagli autori del dossier unicamente per screditare strumentalmente il settore venatorio, tra l’altro senza ragioni fondate e conclusive.
FIdC – Federazione Italiana della Caccia | Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali
Via Garigliano, 57 – 00198 Roma | C.F. 97015310580 | fidc@pec.it | studiericerche@fidc.it | tel. 06/844094207-204
FedercacciaNazionale | www.federcaccia.org
Strumentale e fuorviante è anche l’accusa di cedimento alla lobby dei cacciatori, in quanto in Italia il mondo venatorio non è una lobby economica, bensì una componente importante della società civile che versa consistenti tasse di concessione, quote per la gestione degli ambiti di caccia, investe ogni anno per la biodiversità, sia in tempo che in denaro, attiva migliaia di agenti di vigilanza, partecipa in vari casi ad attività di protezione civile, svolge funzioni di pubblica utilità e molto altro ancora.
Insostenibili sono le insinuazioni che riguardano le deroghe, in quanto tale forma di prelievo è puntualmente regolamentata dalla legge nazionale e dalla Direttiva “Uccelli”, per la cui applicazione le Regioni sono tenute a richiedere il parere dell’ISPRA, al contingentamento dei capi da prelevare, all’individuazione di misure puntuali in ordine ai modi e ai tempi, ai motivi della deroga, alle persone autorizzate e ai sistemi di controllo messi in atto.
Procedure complesse strettamente regolamentate, che di conseguenza risultano esattamente il contrario di quanto asserito, essendo valutate a priori sostenibili e verificabili, nella maggior parte dei casi, in tempo reale.
Italia “cimitero della fauna d’Europa” che provoca “la rabbia di altri Paesi”
Si tratta puramente di slogan senza fondamento, espressioni retoriche che non trovano alcun riscontro in atti della Commissione Europea che, come è noto, è sempre molto attenta alle tematiche venatorie. Fondazione Capellino non cita nemmeno la fonte di queste frasi ad effetto, dimostrando anche in questo caso la tendenziosità e l’infondatezza delle proprie affermazioni. Basti considerare che sino ad oggi nessuna sanzione è mai stata comminata allo Stato Italiano o alle Regioni per infrazioni in materia di caccia.
Secondo il documento in esame “l’Italia spesso non rispetta le normative internazionali sulla caccia”, eppure la normativa italiana è sottoposta a continue verifiche sia da parte della Commissione, sia da parte dei Tribunali italiani e tale quadro a carico dell’Italia non emerge affatto. Dunque, si tratta di considerazioni mutuate eventualmente da ambienti anti-caccia, ma che non trovano assolutamente alcun riscontro ufficiale.
Cani da caccia
Le affermazioni secondo cui i cacciatori abbandonerebbero, maltratterebbero o addirittura ucciderebbero sistematicamente i propri cani da caccia sono del tutto inaccettabili e non riflettono la realtà della generalità dei cacciatori.
1.
Il cane da caccia è un compagno prezioso. Per un cacciatore, il cane non è uno “strumento”, ma un compagno di caccia e parte della famiglia. Cresce con lui, viene curato,
FIdC – Federazione Italiana della Caccia | Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali
Via Garigliano, 57 – 00198 Roma | C.F. 97015310580 | fidc@pec.it | studiericerche@fidc.it | tel. 06/844094207-204
FedercacciaNazionale | www.federcaccia.org
addestrato con pazienza e rispetto, ed è motivo di orgoglio e affetto. I cani da caccia vivono molti anni con i loro conduttori anche quando non possono più partecipare all’attività venatoria.
2.
Condizioni di vita e detenzione. I cani da caccia spesso vivono in casa o in box o recinti, non in gabbia. I box e i recinti debbono essere a norma, per cui sono perfettamente legali e possono offrire sicurezza e benessere al cane. L’importante è che il cane riceva le cure necessarie, possa fare movimento, socializzare e ricevere costante attenzione, come avviene in genere nelle famiglie dei cacciatori. Contrariamente a quanto spesso si afferma nel documento, molti cani da caccia vivono in casa con i loro proprietari (specialmente nelle città) e vengono nutriti con grande attenzione per mantenerli in perfetta forma, essendo degli animali “atleti”. Anche volendo tralasciare la componente affettiva, basterebbe considerare che un cane ben curato, sereno e in salute rende molto meglio anche durante la caccia: per questo viene trattato con attenzione, alimentato in modo equilibrato e seguito regolarmente dal punto di vista sanitario.
3.
La questione degli incidenti. Gli incidenti venatori che coinvolgono i cani sono rari e, quando accadono, nella quasi totalità dei casi si tratta di eventi accidentali. Le ipotesi di “uccisioni mascherate da incidenti” sono affermazioni gravi, ma non sono supportate da prove. Come in qualsiasi ambito sociale, esistono casi isolati di comportamenti inaccettabili, che vanno severamente puniti.
4.
Accuse di abbandono. Le statistiche degli abbandoni, quando attribuite ai cacciatori, si basano su stime non documentate. La maggioranza dei cani abbandonati proviene da contesti diversi (soprattutto cucciolate casalinghe indesiderate, cani da guardia, cani di proprietà incustoditi, ecc.). Sono estremamente rari i casi di cani da caccia che possono perdersi (grazie all’utilizzo dei collari GPS da parte dei cacciatori) soprattutto nella fase di addestramento o nei passaggi di proprietà o all’inizio della stagione venatoria. Da alcuni anni il tema dei cani dispersi si interseca con le molte morti causate dai lupi (vedi più avanti), casi che diversamente potrebbero essere positivamente risolti. È quindi del tutto scorretto attribuire il fenomeno del randagismo ai cacciatori.
5.
Ogni anno in Italia si stima che circa 130.000 animali domestici (cani e gatti) vengano abbandonati o ceduti, con un picco nel periodo estivo (Vedi Vet33+2Help Consumatori+2. Questo dato dimostra che una grandissima percentuale degli abbandoni è compiuta da non cacciatori, poiché la stagione venatoria in estate è molto vicina e il cane viene curato per l’addestramento in quei mesi.
FIdC – Federazione Italiana della Caccia | Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali
Via Garigliano, 57 – 00198 Roma | C.F. 97015310580 | fidc@pec.it | studiericerche@fidc.it | tel. 06/844094207-204
FedercacciaNazionale | www.federcaccia.org
6.
Un mondo fatto di passione e rispetto. La relazione strettissima tra il cacciatore e il cane è fondata sulla fiducia e la comune passione. Addestrare un cane da caccia richiede anni, dedizione e sensibilità. Immaginare che un cacciatore sia disposto a “eliminare” un cane perché non più utile è una distorsione che appartiene a chi non conosce il rapporto autentico che si crea tra l’uomo e il proprio compagno di caccia.
Il pericolo rappresentato dai lupi
Il tema del randagismo da qualche tempo va visto anche alla luce della diffusione del lupo, poiché questo predatore da un lato si rende responsabile di attacchi e predazioni sui cani, non solo da caccia e non solo su quelli randagi, ma dall’altro il lupo stesso è minacciato dal fenomeno dell’ibridazione con i cani domestici (particolarmente accentuato in certi territori).
Dati raccolti dal Coordinamento cacciatrici di Federcaccia dimostrano che nel periodo novembre 2022-agosto 2023, in Italia sono state registrate non meno di 400 predazioni di cani da parte di lupi, integrando sia cani da caccia che cani da compagnia e da guardiania) e circa il 69,7% degli attacchi registrati è risultato mortale per i cani coinvolti (https://www.federcaccia.org/con-federcaccia-il-lupo-arriva-alla-camera-dei-deputati/).
Tuttavia, è importante sottolineare che questi casi non sono distribuiti in modo uniforme sul territorio e i dati raccolti potrebbero essere molto sottostimati, poiché molti attacchi non vengono denunciati e mancano quasi del tutto le informazioni sull’impatto che la predazione da lupo esercita sui cani randagi.
Gestione del cinghiale
Il dossier della Fondazione Capellino afferma che “la caccia viene tradizionalmente utilizzata come principale strumento di controllo, ma la sua efficacia è spesso messa in discussione”. Questa affermazione risulta generica e non tiene conto delle evidenze scientifiche più recenti.
Il dossier, inoltre, non menziona la Peste Suina Africana, grave emergenza sanitaria che ha radicalmente modificato le priorità gestionali in Italia. La presenza della PSA nel territorio nazionale rende il prelievo venatorio non solo utile, ma necessario e urgente per:
1.
Ridurre la densità delle popolazioni di cinghiale, riducendo così il rischio di diffusione del virus.
2.
Creare zone cuscinetto che limitino la progressione dell’epidemia.
3.
Proteggere gli allevamenti suinicoli nazionali, settore economico di rilevanza strategica.
FIdC – Federazione Italiana della Caccia | Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali
Via Garigliano, 57 – 00198 Roma | C.F. 97015310580 | fidc@pec.it | studiericerche@fidc.it | tel. 06/844094207-204
FedercacciaNazionale | www.federcaccia.org
In questo contesto emergenziale, ogni ritardo o limitazione del prelievo comporta rischi sanitari ed economici inaccettabili.
A riprova dell’efficacia e della necessità del prelievo venatorio, si segnala che ISPRA ha recentemente dovuto contemplare l’aumento da tre a quattro mesi come periodo utile per la caccia in braccata al cinghiale.
Questa decisione, adottata dall’organo tecnico-scientifico di riferimento nazionale per la gestione faunistica, conferma che:
1.
Il prelievo venatorio è riconosciuto come strumento gestionale fondamentale.
2.
L’intensificazione dell’attività venatoria è necessaria per raggiungere gli obiettivi di contenimento.
3.
Le metodologie venatorie tradizionali (come la braccata) sono considerate efficaci quando applicate con continuità e intensità adeguate.
Il dossier conclude suggerendo che “l’avvento di predatori naturali come il lupo potrebbe favorire il contenimento dei cinghiali”. Questa affermazione appare scientificamente discutibile per diverse ragioni:
1.
La predazione del lupo sul cinghiale riguarda principalmente individui giovani, malati o deboli, e ha un impatto numerico trascurabile sulle popolazioni di ungulati in buona salute.
2.
Le densità di cinghiale attualmente presenti in Italia sono incompatibili con un controllo efficace attraverso la sola predazione naturale.
3.
I tempi necessari per un eventuale equilibrio predatore-preda sarebbero incompatibili con l’urgenza sanitaria attuale (PSA) e con la necessità di ridurre immediatamente i danni agricoli;
4.
L’espansione del lupo incontra limitazioni ecologiche e sociali che ne rendono improbabile un ruolo risolutivo nella gestione del cinghiale.
Le strategie integrate (recinzioni, dissuasori, monitoraggio) sono certamente utili come misure complementari, ma non possono sostituire il prelievo venatorio, che rimane lo strumento primario, scientificamente comprovato e tempestivo per la gestione del cinghiale.
FIdC – Federazione Italiana della Caccia | Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali
Via Garigliano, 57 – 00198 Roma | C.F. 97015310580 | fidc@pec.it | studiericerche@fidc.it | tel. 06/844094207-204
FedercacciaNazionale | www.federcaccia.org
Errori nella bibliografia citata da Fondazione Capellino
Una semplice analisi dei riferimenti bibliografici citati nel dossier della Fondazione Capellino dimostra che sono presenti numerosi errori e documenti non rintracciabili. Ciò conferma che il dossier è un lavoro approssimativo e non documentato correttamente.
1.
ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (2023). Analisi dei prelievi venatori sulla base dei tesserini regionali 2017–2023. Relazione tesserini venatori da 2017-18 a 2022-23 (PDF) → il testo che si apre cliccando sul link è di novembre 2024, non del 2023 e il titolo è sbagliato.
2.
LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli (2025). Sondaggio SWG su opinione pubblica e riforma della caccia. → il testo che si apre cliccando sul link si intitola “il rapporto degli italiani con la biodiversità e l’avifauna – dati e insight a supporto delle strategie di comunicazione di Lipu – report dei risultati”.
3.
Nomisma (2024). Studio sull’impatto economico della caccia in Italia (commissionato da Federcaccia). → cliccando sul link si apre una pagina che dà “Errore 404”. Inoltre, il titolo dell’opuscolo distribuito da Federcaccia è “Il valore dell’attività venatoria in Italia”.
4.
BirdLife International (2021). European Birds of Conservation Concern: populations, trends and national responsibilities. → cliccando sul link si apre una pagina che dà “Errore 404”, ma inserendo la citazione nella barra di ricerca Google rimanda al pdf della Red List Europea 2021.
5.
WWF Italia / LAV / Legambiente (2023). Rapporti sul bracconaggio e sulla gestione venatoria in Italia. → cliccando sul link si apre il pdf del rapporto Zoomafia 2023, redatto da LAV, con il patrocinio della Fondazione Antonino Caponnetto; WWF Italia, e Legambiente sono citati nel testo per le azioni di volontariato, ma non sono tra gli autori. Il documento non tratta di caccia, ma di bracconaggio, oltre che di combattimenti clandestini, scommesse, contrabbando, commercio illegale di fauna.
6.
EFSA (2012). Lead dietary exposure in the European population. Lead dietary exposure in the European population (EFSA) → citazione errata e link di rimando all’articolo scientifico “Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of vitamin D”, seppur sul sito corretto.
Considerazioni conclusive
Il “Dossier Caccia” della Fondazione Capellino consiste in una classica strategia di marketing aziendale con cui si cerca di legare il marchio ad una causa sociale o ambientale, anche se questa non ha nulla a che fare con i fini aziendali della stessa, ma solo in quanto ritenuta utile come immagine per apparire più autorevoli, per ricevere consensi e per aumentare la propria reputazione e di conseguenza i guadagni.
FIdC – Federazione Italiana della Caccia | Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali
Via Garigliano, 57 – 00198 Roma | C.F. 97015310580 | fidc@pec.it | studiericerche@fidc.it | tel. 06/844094207-204
FedercacciaNazionale | www.federcaccia.org
L’azienda, infatti, non ha preso nessun impegno sistemico e coerente sul benessere animale, anche perché il core business aziendale resta e rimane lo sfruttamento delle carni animali e del pesce utilizzato per i propri prodotti. Non ritenendo utile schierarsi contro il maltrattamento animale determinato dagli allevamenti intensivi o dalla pesca incontrollata (in quanto principali fornitori) preferisce prendersela con la sola caccia in quanto più semplice da attaccare.
Il comportamento di Almo Nature non è quindi altro che un classico esempio di “greenwashing” o più specificatamente di “activism-washing”, dove la causa sociale diventa un mero strumento di marketing piuttosto che una vera trasformazione organizzativa o di un impegno reale alle cause ambientali maldestramente sbandierate nel dossier caccia.
Dott. Michele Sorrenti
Coordinatore Scientifico Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali Federazione Italiana della Caccia
Bibliografia
Andreotti A., Borghesi F. 2012. Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni. Rapporti ISPRA, 158/2012.
Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Deinet, S., Ieronymidou, C., McRae, L., Burfield, I. J., Foppen, R. P., Collen, B., & Böhm, M. (2013). Wildlife comeback in Europe: The recovery of selected mammal and bird species. Final report to Rewilding Europe by ZSL. BirdLife International and the European Bird Census Council. ZSL.
ECHA. Annex XV Restriction Report Proposal for a Restriction. Helsinki, Finland; 2021 Mar.
EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on Lead in Food. EFSA Journal 2010; 8(4):1570. [147 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1570
European Food Safety Authority, 2012. Lead dietary exposure in the European population. Sci. Rep. Efsa. 10 (7), 2831
FIdC – Federazione Italiana della Caccia | Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-Ambientali
Via Garigliano, 57 – 00198 Roma | C.F. 97015310580 | fidc@pec.it | studiericerche@fidc.it | tel. 06/844094207-204
FedercacciaNazionale | www.federcaccia.org
Fustinoni S, Sabrina Sucato, Dario Consonni, Pier Mannuccio Mannucci, Angelo Moretto, Blood lead levels following consumption of game meat in Italy. Environmental Research, Volume 155, 2017, Pages 36-41, ISSN 0013-9351, https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.01.041.
Keel MK, Davidson WR, Doster GL, Lewis LA. Northern bobwhite and lead shot deposition in an upland habitat. Arch Environ Contam Toxicol. 2002 Oct;43(3):318-22. doi: 10.1007/s00244-002-1212-5. PMID: 12202928.
Smart, J., et al. Illegal killing slows population recovery of a re-introduced raptor of high conservation concern – The red kite Milvus milvus. Biol. Conserv. (2010), doi:10.1016/j.biocon.2010.03.002
Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F., 2014. Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e tendenze delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014.
Sitografia
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/suoli/metalli-pesanti/biodisponibilita-metalli-pesanti-nel-suolo
https://echa.europa.eu/it/home
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/are-the-pillars-of-the-eus-lead-ammunition-ban-starting-to-crumble/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/echa-report-on-lead-ammunition-near-total-ban-starting-off-on-the-wrong-foot-once-again/
https://www.ersaf.lombardia.it/wp-content/uploads/2023/07/QdR61_Ramet_13383_394.pdf
https://www.uniurb.it/comunicati/47252